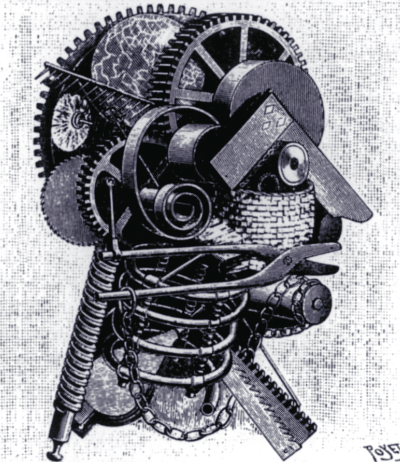NON ABBIAMO BISOGNO DI SERRE, MA DI SCUOLE APERTE!
L’apprendimento per la maggior parte del tempo non avviene nelle scuole
CI VUOLE UN VILLAGGIO PER FAR CRESCERE UN BAMBINO
intervista di Thomas Stöckli a Gerald Hüther

Gerald Hüther, neuroricercatore e direttore del Centro di Ricerche per la Prevenzione Neurobiologica dell’Università di Göttingen e Mannheim/Heidelberg (Germania), è autore di molti libri nel campo della ricerca sul cervello. Thomas Stöckli è un insegnante svizzero di scuola Waldorf.
L’intervista è tratta dalla rivista Erziehungskunst – Waldorfpädagogik heute (Arte dell’educazione – Pedagogia Waldorf oggi), Aprile 2010. Traduzione dal tedesco di Fabio Alessandri.
Thomas Stöckli : Come è andata per lei quando frequentava la scuola?
Gerald Hüther : Nella Germania dell’Est ogni cosa era totalmente strutturata. La scuola non mi coinvolgeva e io speravo che finisse presto. Nonostante questo ho avuto insegnanti che hanno risvegliato il mio interesse in alcune materie.
T.S. Dunque non ha imparato niente a scuola?
G.H. L’apprendimento mnemonico non ha importanza nella vita reale. Noi impariamo dalle nostre esperienze. Dov’è che bambini e ragazzi al giorno d’oggi hanno quelle esperienze che veramente li colpiscono? Le hanno nell’ambiente di gioco, a casa con i loro genitori e facendo dei lavori con i loro compagni, ma non a scuola.
T.S. Cosa si dovrebbe cambiare?
G.H. Non abbiamo bisogno di «serre», dove le piante (cioè i bambini; N.d.T.) siano protette dall’am-biente, ma scuole aperte dove ci sia vita, scuole che incarnino la saggezza africana secondo cui ci vuole un villaggio per il completo sviluppo di un bambino. Le scuole dovrebbero rendere possibili ai bambini e ai giovani esperienze di apprendimento come quelle che si possono trovare in un villaggio – soprattutto l’interazione con molti differenti tipi di persone che non devono essere soltanto insegnanti.
T.S. Ciò viene confermato dalla ricerca neurologica?
G.H. La prima cosa importante da sapere è che il cervello umano non viene costruito secondo programmi genetici, ma si struttura nel corso della vita sulla base di esperienze. Queste esperienze iniziano molto prima di quanto si credeva una volta. I nove mesi di gestazione possono essere visti come il più importante periodo di apprendimento della vita.
Più tardi le esperienze relazionali (relazioni con le prime persone di riferimento, con membri della famiglia, con compagni e amici all’asilo e a scuola) vengono trasformate in reti neuronali. Questo processo continua durante tutta la vita. Il cervello umano è molto più plastico e trasformabile di quello che si è sempre creduto.
T.S. Si può parlare di una modificazione della struttura del proprio cervello durante tutto il corso della vita?
G.H. Sì, l’unico presupposto affinché i vissuti si «ancorino» nel cervello è che si facciano esperienze che rilascino nel cervello trasmettitori chimici neuroplastici. Quando questi trasmettitori chimici vengono rilasciati è come se un «annaffiatoio» cominciasse a versare i fattori di crescita che rendono possibile l’ancoraggio nel cervello delle esperienze e di ciò che è stato imparato.
T.S. In quali situazioni si apre questo «annaffiatoio»?
G.H. Questo succede ogni volta che una persona si entusiasma per ciò che apprende, quando la cosa che si impara ci sembra piena di significato, quando qualcuno è sollecitato, incoraggiato, o ispirato da altri a fare nuove esperienze di apprendimento. L’entusiasmo è essenziale per lo sviluppo del cervello. Perciò la riscoperta dell’entusiasmo nella scuola è un presupposto per la creazione di un diverso tipo di ambiente di apprendimento.
T.S. Ci sono conoscenze ulteriori a questo riguardo?
G.H. I programmi genetici non producono alcuna rete neuronale, ma assicurano che alla nascita sia disponibile il giusto «materiale» per la formazione di un buon cervello. Con i programmi genetici non si può sapere in ultima analisi quante cellule nervose verranno utilizzate per un cervello, né sapere come queste cellule nervose vengano connesse tra loro. Quali di queste possibilità di connessione vengano effettivamente stabilite dipende da quali reti vengono usate e quali no.
Nei bambini che guardano molto la televisione viene costruita la rete-televisione; in quelli che giocano a calcio viene costruita la rete-calcio. Il potenziale di un bambino al momento della nascita è molto più grande di quanto non sia al termine dell’educazione e della formazione. Il compito della scuola perciò dovrebbe essere di utilizzare questo potenziale, vale a dire risvegliare l’entusiasmo nel bambino, non solo insegnargli ad appropriarsi di contenuti culturali, ma anche dare un proprio contributo originale.
Col passare degli anni noi perdiamo la capacità di entusiasmarci per quello che riusciamo a fare. Un bambino di tre o quattro anni prova ogni giorno forse quaranta o cinquanta volte delle «tempeste» di entusiasmo. Un ragazzo prova forse ancora una volta al giorno un’esperienza di successo, una persona di mezza età una volta alla settimana. Non parlo di una gioia fugace, ma di vero entusiasmo che attiva l’ «annaffiatoio» di cui ho parlato prima.
T.S. Come stanno le cose per l’anziano? Può per esempio un ottantacinquenne imparare ancora il cinese?
G.H. Forse non può riuscirci all’università popolare, perché lì manca l’entusiasmo necessario. Se però la persona in questione si trasferisce in Cina con una cinese settantacinquenne, dopo sei mesi potrebbe parlare cinese.
T.S. Dobbiamo allora pensare che sia auspicabile avere quante più esperienze possibili?
G.H. I bambini hanno bisogno di un ambiente nel quale vengano soddisfatte due condizioni di base: ogni giorno devono poter crescere un po’ oltre se stessi e sentire che nel loro ambiente ci sono possibilità di sviluppo, e oltre a ciò devono sperimentare come esistano comunità nelle quali si è protetti. Se una di queste due condizioni passa troppo in secondo piano il bambino vive un senso di insoddisfazione, che lo porta a sperimentare insicurezza, paura e stress, perché le sue aspettative non sono soddisfatte. Allora il bambino stesso deve trovare una soluzione. Spesso i bambini trovano simili soluzioni in forma di soddisfazioni sostitutive come videogiochi e televisione, ma poiché questi li soddisfano solo momentaneamente, ne hanno bisogno sempre di più. Questi bambini perdono interesse per la collaborazione a processi di trasformazione del mondo e si focalizzano su come ottenere il più possibile dal poco che hanno trovato. Facendo questo perdono di vista gran parte del mondo e si privano di molte cose. Dal punto di vista dello sviluppo del cervello questo stato di cose produce una versione molto impoverita di ciò che sarebbe potuto essere.
T.S. Da cosa si capisce se una scuola offre un simile ambiente di apprendimento?
G.H. Lo si capisce dal fatto che gli alunni ci vanno volentieri e sono tristi quando cominciano le vacanze.
T.S. Questo però succede in pochissime scuole. Come si potrebbe cambiare il sistema scolastico?
G.H. Al momento si sta provando ad adattarsi ad un sistema educativo che risale all’epoca dell’indu-strializzazione: gli studenti vengono suddivisi nelle scuole di diverso ordine a seconda delle loro prestazioni, con il risultato che alla fine emerge solo ciò che è consentito da simili condizioni.
La scuola nella nostra società incoraggia la spinta alla prestazione e la competizione. Se però i bambini devono competere tra loro e la paura di fallire viene alimentata, allora una cultura scolastica come quella che io immagino è del tutto impossibile, allora gli studenti ripiegano su atteggiamenti volti a far fronte all’emergenza e si preoccupano solo di come sopravvivere alla scuola. Entusiasmo, spirito di scoperta e forze formative in questo caso vanno perdute.
T.S. Che conclusioni si devono trarre da ciò?
G.H. Si dovrebbe eliminare dalle scuole ciò che crea pressione, abolire i voti e spingere gli studenti alla scoperta personale e alla creazione. Per far questo ci sarebbe bisogno di insegnanti che non si considerino degli esecutori, ma autorità pedagogiche capaci di dare una direzione ai propri alunni. Un insegnante che non è in grado di costruire un rapporto personale con gli studenti non può interessarli. Un insegnante capace di incoraggiare gli alunni deve essere coraggioso. Oggi molti insegnanti presi dalla routine della scuola si sono scoraggiati. Un insegnante dovrebbe essere capace di entusiasmare gli studenti, sollecitandoli a fare nuove esperienze formative; non dovrebbe ad esempio essere entusiasta della matematica in sé, ma della possibilità di entusiasmare i suoi studenti per la matematica. Si tratta di una forma di entusiasmo del tutto diversa, che pochissimi insegnanti hanno e che secondo me non si può imparare neanche in cinque anni di studio universitario.
T.S. Oltre agli insegnanti non dovrebbero cambiare modo di pensare anche i genitori?
G.H. Anche se si cambiassero le cose come ho detto, l’impresa non potrebbe riuscire senza una trasformazione di coscienza da parte dei genitori. Molti genitori hanno avuto esperienze negative a scuola e credono che ora anche i loro figli debbano avere le stesse brutte esperienze. A questo scopo molti genitori delegano la responsabilità educativa alla scuola. La scuola però non è il luogo in cui ci si può dedicare a quello che dovrebbe succedere in famiglia. Per i bambini invece è essenziale occuparsi insieme di qualcosa, avere qualcosa a cui rivolgere insieme l’attenzione.
T.S. Perché?
G.H. Simili esperienze comunitarie sono il presupposto affinché il bambino possa crescere all’intero di una società individualistica come quella che abbiamo oggi. Nelle famiglie in cui questo non è riuscito i bambini rimangono legati ad una relazione primitiva di dipendenza, sempre incentrata sul «due». Questi bambini non sono in condizione di includere un terzo elemento comune. Con ciò non si intende una serata insieme di fronte alla televisione. I bambini che non hanno interiorizzato come esperienza questa attenzione suddivisa non sono capaci di seguire delle lezioni, non conoscono alcun rapporto nato dal fare qualcosa insieme agli altri. Simili bambini disturbano; o vengono esclusi dal gruppo o si chiudono in se stessi. Perciò è nell’interesse di tutti risvegliarsi e accorgersi che con le nostre stesse strutture sociali stiamo distruggendo il fondamento su cui poggia la nostra cultura.
T.S. In quali situazioni di apprendimento i bambini possono con un’attenzione suddivisa fare esperienze che li aiutino nel loro sviluppo?
G.H. La risposta è banale: facendo canto corale, musica, teatro, lavori manuali e di costruzione. Queste esperienze di apprendimento appartengono al campo musicale-estetico, che nel nostro attuale sistema scolastico viene considerato poco significativo.
Al momento il nostro sistema scolastico è disperatamente individualizzato. I bambini si occupano solo dei propri affari. Noi chiamiamo questo egocentrismo, ma in realtà i bambini stanno solo mostrandoci come li abbiamo privati di determinate esperienze, come per esempio cucinare insieme o guardare insieme un libro illustrato. Sono convinto che noi come società non saremo capaci di progredire, se la scuola non offrirà maggiori opportunità di prendere parte a iniziative sociali e mi domando che cosa si svilupperà da una società di individualisti come la nostra.